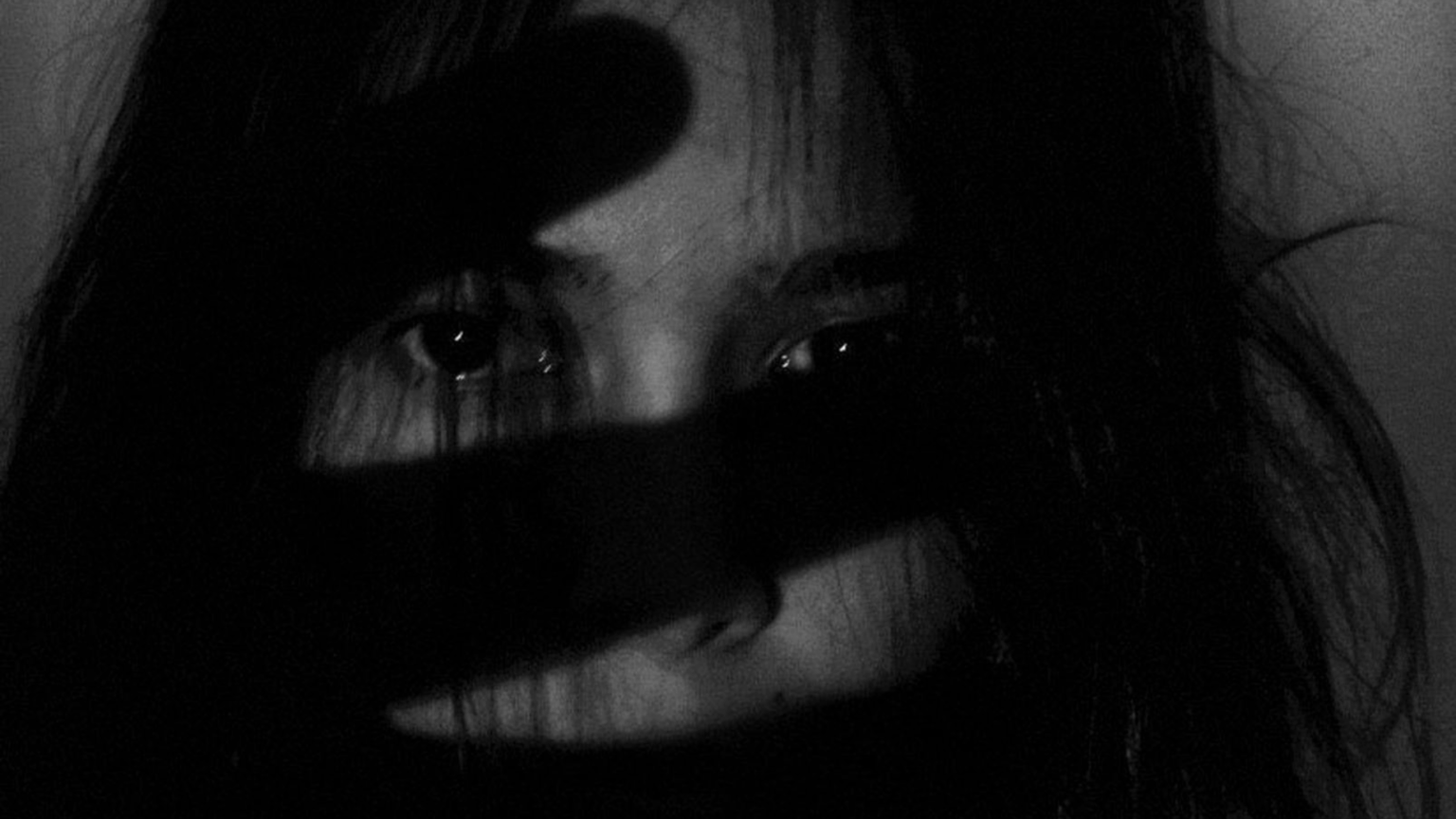Sono ormai entrate nell’uso comune soluzioni di IA applicate alla medicina, alla difesa, ai trasporti, alla domotica, alle attività industriali e a tutto ciò che si può utilizzare per costruire modelli predittivi.
Interagire e venire a contatto con automated machines e con strumenti innovativi che ci consentono di viaggiare, collegarci ad internet, interagire con terzi, svolgere semplici mansioni quotidiane ed altro, è pratica quotidiana. Una attività del tutto disruptive, una dirompenza più o meno inconscia.
Leggi Anche
L’uso di algoritmi di machine learning ha influenzato anche la giustizia: l’apprendimento automatico si affaccia all’interno dei processi, nelle aule di tribunali e negli studi professionali. Oramai, sistemi e strumenti complessi sono in grado di prevedere il possibile esito di una controversia.
La Francia ha raccolto la sfida della giustizia predittiva
A livello europeo la Francia è tra gli Stati più intraprendenti e sensibili al tema della giustizia predittiva, emanazione del machine learning. Sono diffuse le iniziative, imprenditoriali e non, volte ad accogliere in maniera efficace le sfide lanciate dalla giustizia predittiva. Ne sono un esempio taluni progetti realizzati da alcune Università italiane o la progettazione – da parte di giovani startupper – di innovativi software in grado di prevedere le probabilità di successo o insuccesso del processo in base ad un calcolo statistico. Il software “Predictice”, sviluppato da una start up innovativa francese, rappresenta solo la punta di un iceberg in continua emersione.
AI a supporto della Giustizia Amministrativa: arriva PRO.DI.GI.T.
Il legislatore italiano ha recentemente dato avvio al c.d. “Progetto di digitalizzazione e creazione di servizi innovativi a supporto della Giustizia Tributaria. PRO.DI.GI.T, così si chiama il progetto, è stato finanziato con le risorse del REACT-EU facente capo al “Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”. L’iniziativa si prefigge di migliorare la credibilità, l’affidabilità, l’autorevolezza e l’efficienza della giustizia tributaria, tramite creazione di prassi virtuose che coinvolgano i principali attori interessati dal progetto: magistrati, accademici, professionisti e tecnici del digitale, ma anche cittadini ed imprese.
L’obiettivo è migliorare il livello di digitalizzazione delle attività interne al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, reingegnerizzando il sito del Consiglio stesso, al fine di assicurarne una maggiore fruibilità, e implementando la banca dati nazionale di giurisprudenza di merito nell’ambito del sistema informativo del MEF.
L’algoritmo, che è in fase di progettazione, consentirà di confrontare gli elementi principali della fattispecie concreta con le decisioni indicizzate nella banca dati, restituendo il probabile esito della lite: ciò permetterà al cittadino – da una parte – di comprendere l’orientamento giurisprudenziale e i propri diritti e al giudice – dall’altra – di ricevere supporto nella fase di studio della causa e redazione della decisione.
La Giustizia Tributaria e la ratio dell’accessibilità alla conoscenza delle norme
La ratio di tale iniziativa è chiara: garantire massima accessibilità alla conoscenza delle norme da parte dei consociati e dunque orientare l’agire umano, perseguire stabilità e linearità della regolamentazione nel tempo, perseguire efficacia dei comandi, univocità delle qualificazioni giuridiche e prevedibilità del contenuto delle decisioni, arginare e temperare la discrezionalità dell’organo giurisdizionale.
D’altra parte, l’esigenza e la necessità di applicare formule matematiche ed algoritmi alla realtà quotidiana e, in particolare, al mondo del diritto hanno origini antiche, avendo influenzato la storia giuridica dal medioevo ad oggi.
L’aspirazione ad una maggiore certezza del diritto nasce, invero, con l’istituto controverso della communis opinio doctorum con l’intendo di limitare l’arbitrium iudicis, ancorando il contenuto della sentenza alle opinioni espresse dai doctores più illustri.
Nel corso degli anni tale dibattito si è poi sviluppato, seppur in forme e contesti differenti, passando per celebri autori quali: ex multis Raimondo Lullo, per il quale il diritto è entità tanto calcolabile quanto prevedibile, Leibnitz, sviluppatore di teorie legate alla calcolabilità delle sentenze, Voltaire secondo cui lo studio delle probabilità è la scienza dei giudici, Beccaria e gli Illuministi, sino ad arrivare al più attuale autore Max Weber, che razionalizza il diritto a fini economici e nell’ambito di una più ampia teoria sociologica.
AI verso un uso costituzionalmente orientato e dominio umano nella procedura
Sul tema, la stessa giurisprudenza è intervenuta – a più riprese – al fine di rendere l’utilizzo dell’IA “costituzionalmente orientato”, tanto utile e vantaggioso quanto pericoloso ed insidioso.
Il Consiglio di Stato, con due sentenze gemelle pubblicate il 13 dicembre 2019 (la n. 2936 e la n. 8474del 2019), ha confermato e riconosciuto gli indubbi vantaggi legati al ricorso ad algoritmi ed IA nella Pubblica Amministrazione (i.e con particolare riferimento alle ipotesi in cui le decisioni da adottare non dipendono dall’esercizio di un potere discrezionale ma si fondano su criteri oggettivi e vincolanti, tale da garantire il buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.), chiarendo – al contempo – la necessità che vi sia conoscibilità degli algoritmi stessi, “non esclusività” della decisione algoritmica e, soprattutto, residui un dominio umano nella procedura.
Europa: carta etica per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia
A livello europeo, la Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa, il 4 dicembre 2018, ha emanato la “Carta etica europea per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti”.
Tale documento, al quale si rimanda per un approfondita conoscenza, risulta di eccezionale rilevanza – a conferma della necessità di mantenere un approccio umano ed etico in tutte le decisione del caso concreto – poiché per la prima volta a livello europeo, preso atto della “crescente importanza della intelligenza artificiale (IA) nelle nostre moderne società e dei benefici attesi quando questa sarà pienamente utilizzata al servizio della efficienza e qualità della giustizia”, vengono individuate fondamentali linee guida per “i soggetti pubblici e privati responsabili del progetto e sviluppo degli strumenti e dei servizi della IA” tra cui, inter alia, i) il principio del rispetto dei diritti fondamentali; ii) il principio di non discriminazione; iii) il principio di qualità e sicurezza; iv) il principio di trasparenza; v) il principio di garanzia dell’intervento umano.
AI e le esigenze etiche e di giustizia di non affidarsi completamente ad un algoritmo
Il bisogno di certezza del diritto ha spinto il legislatore ad approfittare degli attuali sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale al fine di semplificare ed orientare l’agire umano, ovvero facilitare il compito nomofilattico dei giudici.
Al contempo, esigenze etiche e di giustizia, impediscono di pensare ad un giudice completamente sostituito da un robot o da un algoritmo, svincolato in toto dalla realtà e dalle circostanze specifiche del caso concreto.
Un’indagine umana della fattispecie rimane una necessità imprescindibile derivante dalle norme e dai principi costituzionali – quali il principio di Legalità e il Giudice naturale precostituito per legge – soprattutto nei casi in cui risulti opportuno e necessario ricorrere ad un prudente apprezzamento e ad un’ampia discrezionalità, applicando – a mero titolo esemplificativo – clausole quali buona fede, correttezza ed equità.
© Riproduzione riservata