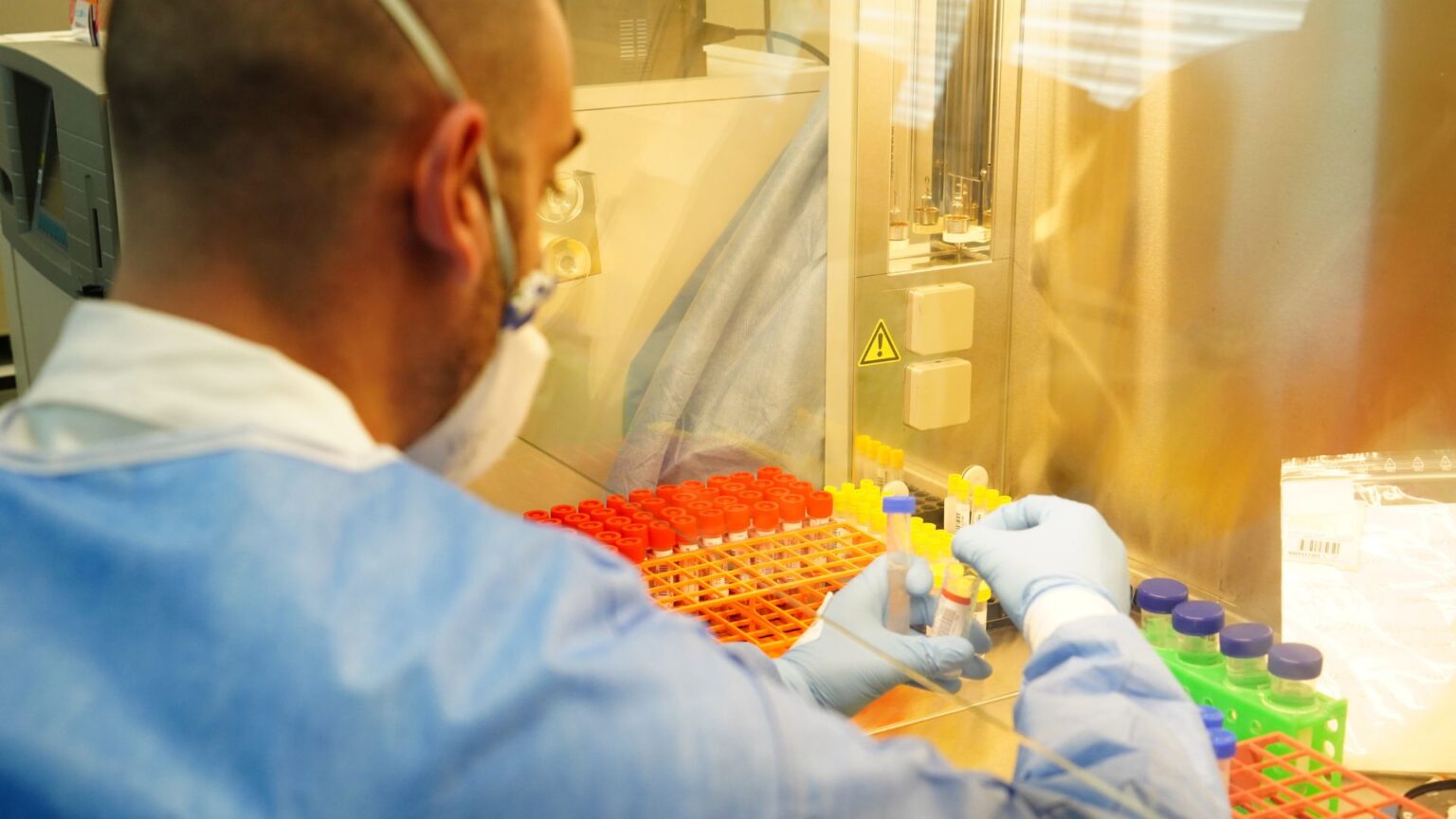L’intervista all’insegnante Stefano Tramonti: “Da amante del mio territorio dico che serve amore, anche dal punto di vista istituzionale. C’è incuria, c’è l’eccezionalità dell’evento, ma c’è anche poco amore”
Le città romagnole sono ancora sott’acqua. Il territorio resiste per la rete di persone che lo tengono insieme e che lavorano senza sosta, “con amore”, spalando fango “dall’alba e finché c’è luce”. “È la Romagna più bella”, dove “nessuno si è mai sentito solo” e dove tutti “si sono rimboccati le maniche”, letteralmente.
A quasi quattordici giorni dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna con danni incalcolabili per quattro province e soprattutto pezzi di vita disciolti nel fango ormai irrecuperabili, trapela la commozione agrodolce di chi è alle prese con il post-evento catastrofico. Il proprio territorio è sfigurato; le città si asciugano, ma sono irriconoscibili e impraticabili; la ricostruzione comincia, ma non si vede e non si vedrà per molto tempo.
Leggi Anche
Stefano Tramonti, insegnante, padre di “una famiglia di sfollati” – come tante – e responsabile provinciale del dipartimento di Disabilità ed Equità sociale di Fratelli d’Italia parla al Difforme, descrivendo le città prima sommerse e ora a mano a mano asciutte, lo spirito di collaborazione, le “spie di normalità” nella disperazione. “Ieri – racconta – ero in call con la mia classe. È stato bello notare che tanti ragazzi fossero assenti perché a spalare fango”. “I miei studenti – aggiunge – sono straordinari. È la cosa che mi ha toccato di più”. “Le scuole sono ancora chiuse, le città sono, sì, parzialmente asciutte, ma la viabilità è compromessa. Non abbiamo strade, ponti, ferrovie. Si tratta dell’impossibilità totale di raggiungere un posto”, osserva frustrato. “Via Faentina (la via principale ndr) che collega Ravenna a Bologna è ancora chiusa. Verrà forse riaperta nei prossimi giorni”. Si vive nei forse e nei ma, “con apprensione”.
Un po’ di numeri: il ricordo del terremoto del 2012
I numeri dell’alluvione in Emilia-Romagna sono raccapriccianti. Oltre 7 miliardi di euro di danni – stando a una prima stima ufficiosa delle parti sociali – 15 morti, quasi 40mila sfollati, 23 fiumi esondati contemporaneamente, oltre 280 frane, di cui 120 particolarmente importanti, più di 100 comuni coinvolti, quasi 5mila uomini della protezione civile impegnati giorno e notte ad assistere la popolazione. Quasi “un nuovo terremoto”, come lo ha definito il presidente della Regione Stefano Bonaccini, paragonando l’evento al sisma del 2012 che causò danni per 13 miliardi e 273 milioni di euro (secondo la relazione inviata alla commissione Ue).
Quello del 2012, era stato definito “il terremoto dei capannoni”. Per la prima volta, infatti, le scosse colpivano una zona altamente produttiva e caratterizzata da insediamenti industriali. Edifici realizzati con sistemi di prefabbricazione pesante e non tenuti al rispetto delle normative antisismiche (perché in un’area definita a basso rischio) venivano giù come un castello di carte.
Tornando all’alluvione, “case e aziende – prosegue il professor Tramonti – sono completamente distrutte”. “Quest’alluvione – ecco, il centro nevralgico della questione – ha colpito una delle zone più ricche d’Italia. Per il settore agroalimentare, la più importante. I comuni della provincia di Ravenna, come Conselice o Lugo, sono ancora sott’acqua. Quanto ci vorrà esattamente nessuno è in grado di dirlo. Il territorio colpito è immenso, costituito da città popolose. Tutte le aziende sono in ginocchio. È quello che stiamo patendo di più”.
E le scuole?
Intanto, dopo il sopralluogo nell’Emilia Romagna alluvionata, la premier Giorgia Meloni aveva promesso un primo intervento del governo da 20 milioni di euro. “Mi ha colpito la reazione della gente, bisogna essere alla loro altezza”, aveva dichiarato. E così ha dato un input ai ministri: “Trovate tutte le risorse disponibili da usare subito, senza fare deficit”. Due giorni più tardi ha potuto snocciolare le misure del decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che vale cento volte tanto: oltre 2 miliardi di euro. Fra questi, 20 milioni sono destinati ad affrontare le prime urgenze del sistema scolastico. “Occorre garantire la continuità didattica e il ripristino delle attività”, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara. E l’insegnante osserva infatti: “Sono provvedimenti presi per l’emergenza, non per la ripresa completa. Si potrà dire qualcosa quando tutto sarà perfettamente agibile”.
La questione ambientale è una questione di amore
La questione ambientale, che si lega a doppio filo con quella dell’inspessimento della vulnerabilità sociale, colonizza a sprazzi il dibattito politico. È dal 2018 che al ministero dell’Ambiente c’è una bozza del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), ma per anni è rimasta ferma lì, come se non fosse una priorità. Con quest’ultimo disastro in Emilia-Romagna, in molti (a partire da Wwf e Legambiente) hanno chiesto al governo l’immediato varo del Pnacc, insieme delle azioni per prevenire o ridurre i danni causati dall’innalzamento delle temperature, dovuto all’effetto serra di origine umana. Il dossier è ampio: la sua approvazione si fa impellente, ma il tempo continua a passare.
Cosa resta allora da pensare? “Da amante della Romagna, del mio territorio, del paesaggio, dico che serve amore. Un maggiore amore per la terra, anche dal punto di vista istituzionale. C’è incuria, c’è l’eccezionalità dell’evento, ma c’è poco amore”. Congedarsi dal professor Tramonti è complicato. Il racconto che fa della tragedia è vivido, perché ne emerge il danno più grande che provoca la calamità naturale: il furto della normalità. “Forse domani riaprono le scuole – tentenna – la normalità sarebbe già questa”.
© Riproduzione riservata