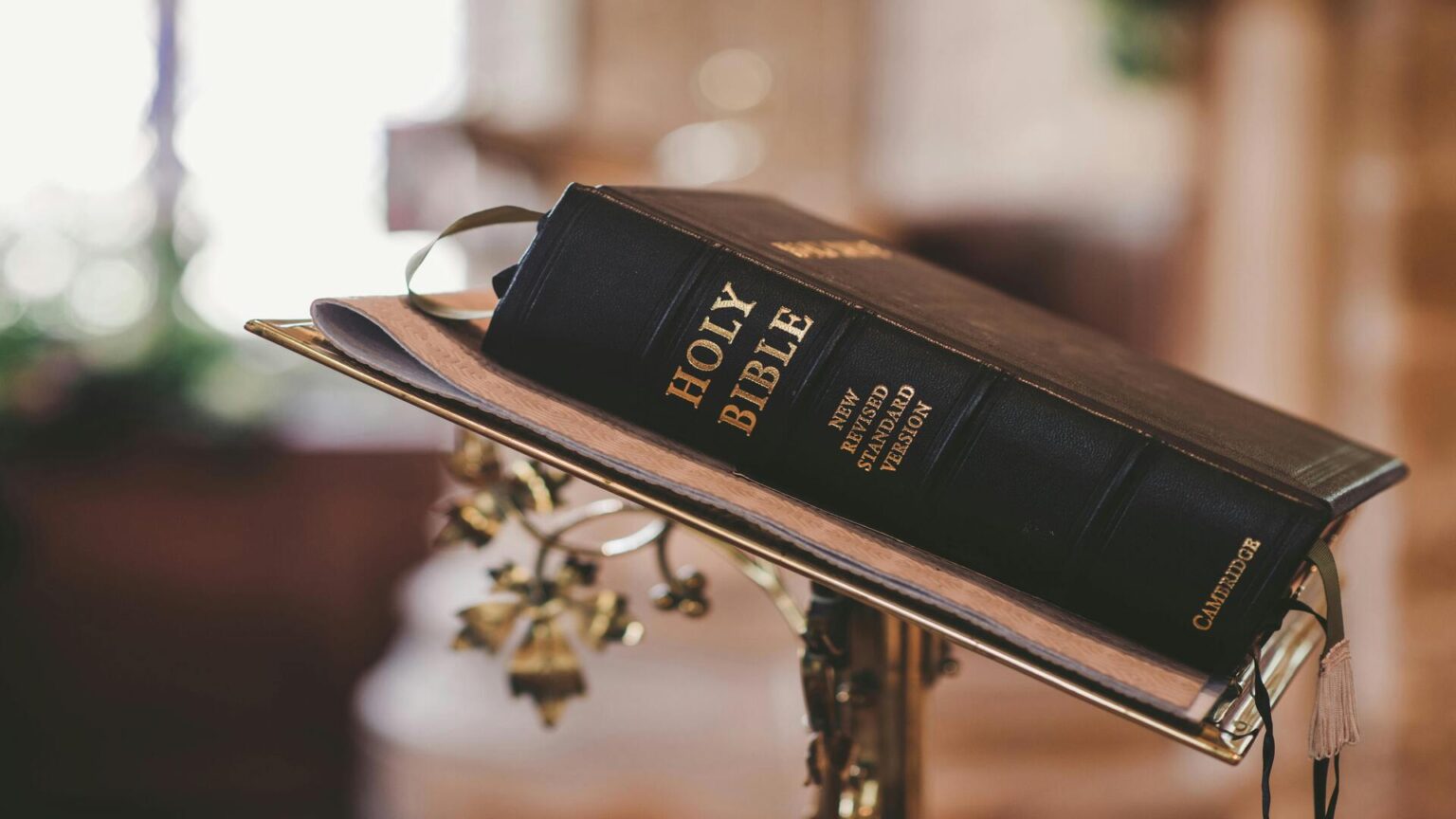Qualcosa che chiunque può comprendere, come fosse un linguaggio universale: i meme. Inizialmente sembravano essere semplici battute in formato immagine, ma in pochi anni hanno preso il sopravvento, invadendo ogni angolo di internet e dei social.
Dall’ironia più leggera alla satira politica tagliente, i meme sono diventati il linguaggio predominante della rete, un mezzo per riflettere sulla realtà senza mai prendersi troppo sul serio. Ma il loro ruolo va ben oltre la semplice battuta: sono strumenti di commento sociale, capaci di condensare fenomeni complessi e di renderli accessibili a tutti.
Leggi Anche
L’emergere della cultura dei meme
Richard Dawkins, biologo evoluzionista, nel 1976 coniò il termine “meme” in Il gene egoista per descrivere un’unità di cultura che si diffonde attraverso l’imitazione. Infatti, per sua natura, il meme è sintetico, immediato e replicabile e racchiude in poche parole concetti, stati d’animo o critiche sociali accessibili ad un pubblico amplissimo.
I primi meme sono nati alla fine degli anni ’90 ma è solo dal 2010, grazie alla diffusione dei social media, che si sono sviluppati i template: immagini di base che venivano ripetutamente modificate con diversi testi. Esempi sono LOLcats, foto di gattini con didascalie sgrammaticate e infantili, i Rage Comics, che utilizzavano strisce di fumetti con faccine che esprimevano emozioni esagerate, e i Trollface.
Tra immediatezza, satira e perdita di profondità
La domanda è: il meme è uno specchio intelligente della nostra società o un suo riflesso deformato? Questa forma di comunicazione si distingue per la capacità di mescolare satira, critica e umorismo, come fosse un piccolo manifesto culturale o un pamphlet ottocentesco. Infatti, spesso hanno accompagnato critiche ad eventi politici, crisi internazionali o fenomeni sociali virali.
Le caratteristiche principali dei meme seguono logiche simili alla poesia satirica o all’aforisma: condensazione, ambiguità e ironia. La differenza è oggi non bisogna più argomentare. Questo perché è diventato veicolo di cultura popolare, che deve essere semplificato estremamente, in modo da mantenere il significato tra diversi contesti socio-culturali. Per questo rappresenta a pieno ciò che Henry Jenkins definiva “cultura convergente“.
Da un lato si potrebbe affermare che la satira 2.0 sia una battuta visiva adattata ai tempi di Instagram e TikTok, dall’altro la dimensione virale impone tempi rapidi e semplificazioni che non lasciano spazio all’argomentazione. Il rischio è che l’informazione venga ridotta a puro intrattenimento e che si arrivi ad una cultura che privilegia solo il semplificato e il condivisibile.
Un linguaggio da non sottovalutare
Dalla retorica classica alle avanguardie novecentesche, ogni epoca ha sperimentato e trovato nuove forme per esprimere la complessità del proprio tempo. Possiamo quindi scegliere tra due vie: usare i meme come nuova forma di alfabetizzazione critica per avvicinare le masse a temi complessi, o considerarli solo strumenti di distrazione e riso.
A questo punto, la domanda non è più se questa forma di comunicazione sia o meno cultura, ma quale cultura stia effettivamente costruendo. Il rischio concreto potrebbe non essere la semplificazione intrinseca del meme, ma il nostro accontentarci della sua semplicità.
© Riproduzione riservata