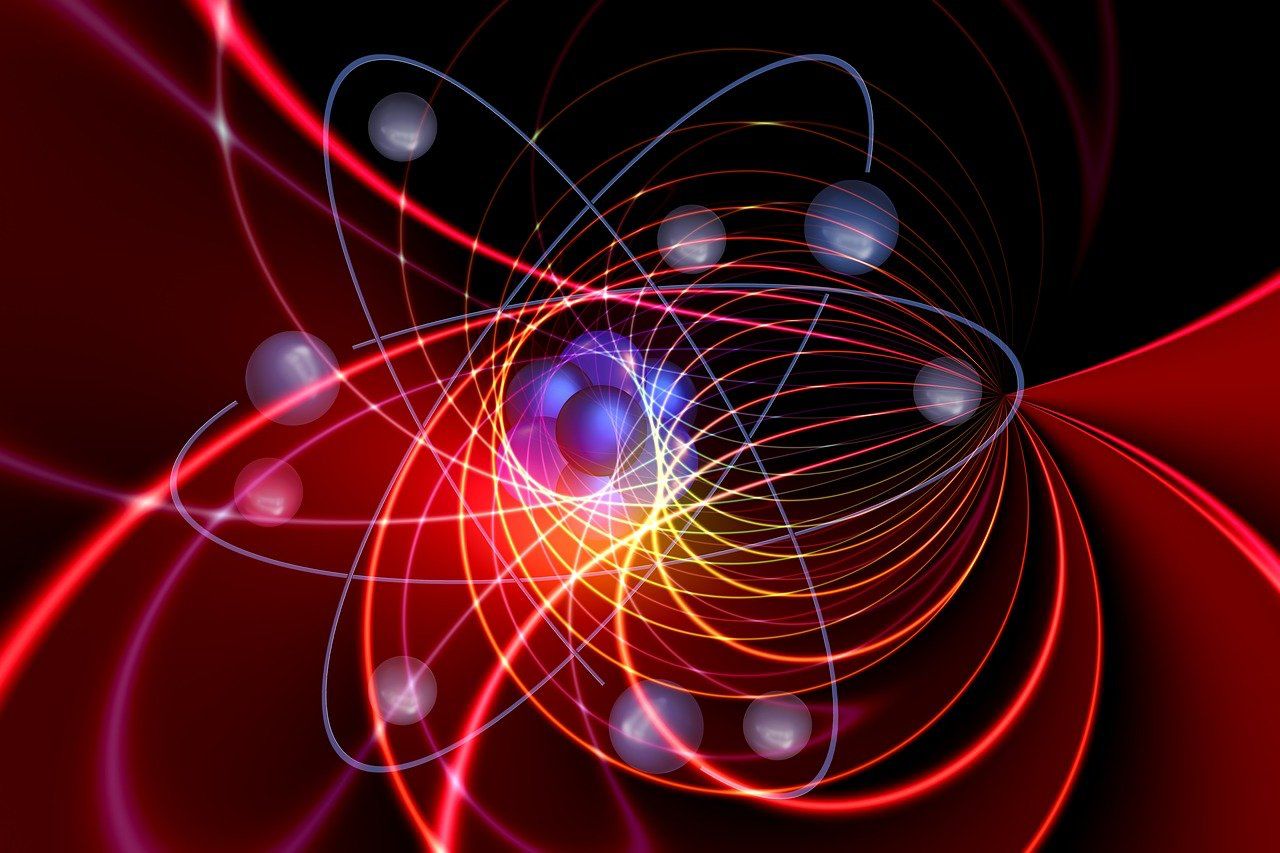A oltre dieci anni dalla sua elezione, il pontificato di Papa Francesco si conferma uno dei più discussi e complessi della storia recente della Chiesa cattolica. Primo Papa gesuita e latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio fu accolto con entusiasmo come un innovatore: un pastore “venuto dalla fine del mondo” per riportare al centro del Vangelo i poveri, la misericordia e la giustizia sociale.
Sin dai suoi primi discorsi, Francesco ha invocato una “Chiesa in uscita”, meno autoreferenziale e più vicina agli ultimi. Tuttavia, la riforma della Curia romana – cuore del potere vaticano – si è rivelata un’impresa ardua. La costituzione apostolica Praedicate Evangelium, varata nel 2022, ha ridisegnato la struttura della Santa Sede, introducendo novità come l’affidamento di dicasteri anche ai laici. Ma nei fatti, i meccanismi interni di potere sono rimasti in larga parte invariati.
Leggi Anche
Particolarmente delicato è stato il settore finanziario: nonostante gli sforzi per promuovere trasparenza, le riforme si sono arenate tra scandali (come il caso dell’ex cardinale Becciu) e le manovre oscure dell’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria). I tentativi di moralizzazione si sono spesso scontrati con reti di potere dove spiritualità e interessi economici si intrecciano pericolosamente.
Francesco ha sempre riconosciuto la presenza di forti opposizioni interne. In più occasioni ha parlato dei “lupi” che lo circondano, riferendosi in particolare ai settori più conservatori del clero. Le critiche hanno toccato numerosi temi: dall’apertura verso i divorziati risposati e la comunità LGBTQ, al dialogo con l’Islam e al Sinodo sulla sinodalità. Alcuni cardinali, come Burke, Müller e Sarah, sono divenuti veri e propri simboli dell’opposizione. Ironia della sorte, proprio molti di loro siederanno nel prossimo Conclave.
Durante il suo pontificato, Papa Francesco ha anche dato impulso a una delle vicende più dolorose del Vaticano: il caso di Emanuela Orlandi. La scomparsa della quindicenne cittadina vaticana nel 1983 ha avuto un nuovo impulso investigativo nel gennaio 2023, quando il promotore di giustizia Alessandro Diddi ha riaperto ufficialmente le indagini con il sostegno del Papa. Francesco ha espresso pubblicamente la sua vicinanza alla famiglia Orlandi, dichiarando: “In Vaticano soffriamo ancora tanto per la scomparsa, avvenuta più di quarant’anni fa, di una nostra cittadina, Emanuela Orlandi. Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare la mamma.”
Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione tra il Pontefice e i familiari di Emanuela. Pietro Orlandi ha più volte richiesto invano un incontro personale con Francesco. In un’occasione, il Papa avrebbe affermato: “Emanuela sta in cielo”, aggiungendo però di non poterlo ricevere perché “troppi occhi” erano puntati su di lui. Dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, Pietro Orlandi ha dichiarato amaramente: “È il terzo Papa morto senza rivelare la verità, ammesso che ne fosse a conoscenza.”
Nel frattempo, le tensioni all’interno del Collegio cardinalizio si sono acuite. Il 24 aprile 2025, il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller ha rilasciato dichiarazioni significative: “Con la morte di Francesco si chiude un’era. Il prossimo Papa dovrà essere successore di Pietro, non del suo predecessore.”
Müller ha criticato le “ambiguità” su temi come l’omosessualità, il ruolo delle donne nella Chiesa, il dialogo interreligioso e l’accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. Ha espresso preoccupazione per una deriva verso il relativismo e ribadito che la Chiesa non può diventare un’organizzazione umanitaria o un forum politico.
Con l’età avanzata e la salute precaria che hanno accompagnato gli ultimi anni di Francesco, la domanda sul futuro pontefice è diventata sempre più pressante. Il prossimo Conclave si annuncia incerto e decisivo: un vero spartiacque tra continuità e cambiamento. Tra le ipotesi più discusse, emerge quella dell’elezione di un “Papa di transizione”: una figura autorevole, anziana, capace di garantire stabilità e preparare la Chiesa a una futura fase di rinnovamento più profondo.
Papabili più citati:
- Pietro Parolin (Italia, 70 anni): Segretario di Stato, uomo di dialogo, vicino a Francesco, ma conservatore su alcune questioni morali.
- Jean-Claude Hollerich (Lussemburgo, 66 anni): Progressista, aperto sul celibato sacerdotale e le unioni omosessuali.
- Luis Antonio Tagle (Filippine, 67 anni): Considerato l’“asiatico francescano”, attento ai poveri e alle periferie.
- Matteo Zuppi (Italia, 69 anni): Presidente CEI, promotore del dialogo e dei temi sociali, vicino alla Comunità di Sant’Egidio.
- Fridolin Ambongo (RD Congo, 65 anni): Voce africana della giustizia sociale e dell’ecologia integrale.
- Péter Erdő (Ungheria, 72 anni): Tradizionalista di profonda formazione teologica.
Un’elezione africana o asiatica sarebbe un forte segnale di universalità, ma i timori di divisioni interne potrebbero spingere verso una figura di compromesso. Il pontificato di Papa Francesco sarà ricordato per il suo linguaggio profetico, l’attenzione alle periferie e la denuncia dei mali strutturali della Chiesa. Tuttavia, sarà anche giudicato per le riforme incompiute. Ha cercato di aprire porte, ma si è spesso trovato a lottare in corridoi chiusi. Ha scosso il cuore dei fedeli, ma ha irritato le élite ecclesiastiche.
Forse il suo lascito più autentico non risiederà nelle strutture, ma nella visione di una Chiesa più umile, inquieta e meno preoccupata del potere.“Futuro Pontifici, quem Dominus eliget, precamur ut Spiritus Sanctus illum repleat sapientia, fortitudine et caritate ad Ecclesiam suam sancte gubernandam.” (Per il futuro Pontefice, che il Signore sceglierà, preghiamo affinché lo Spirito Santo lo riempia di sapienza, fortezza e carità per guidare santamente la Sua Chiesa.). Nell’attesa di Papa Pietro II.
© Riproduzione riservata