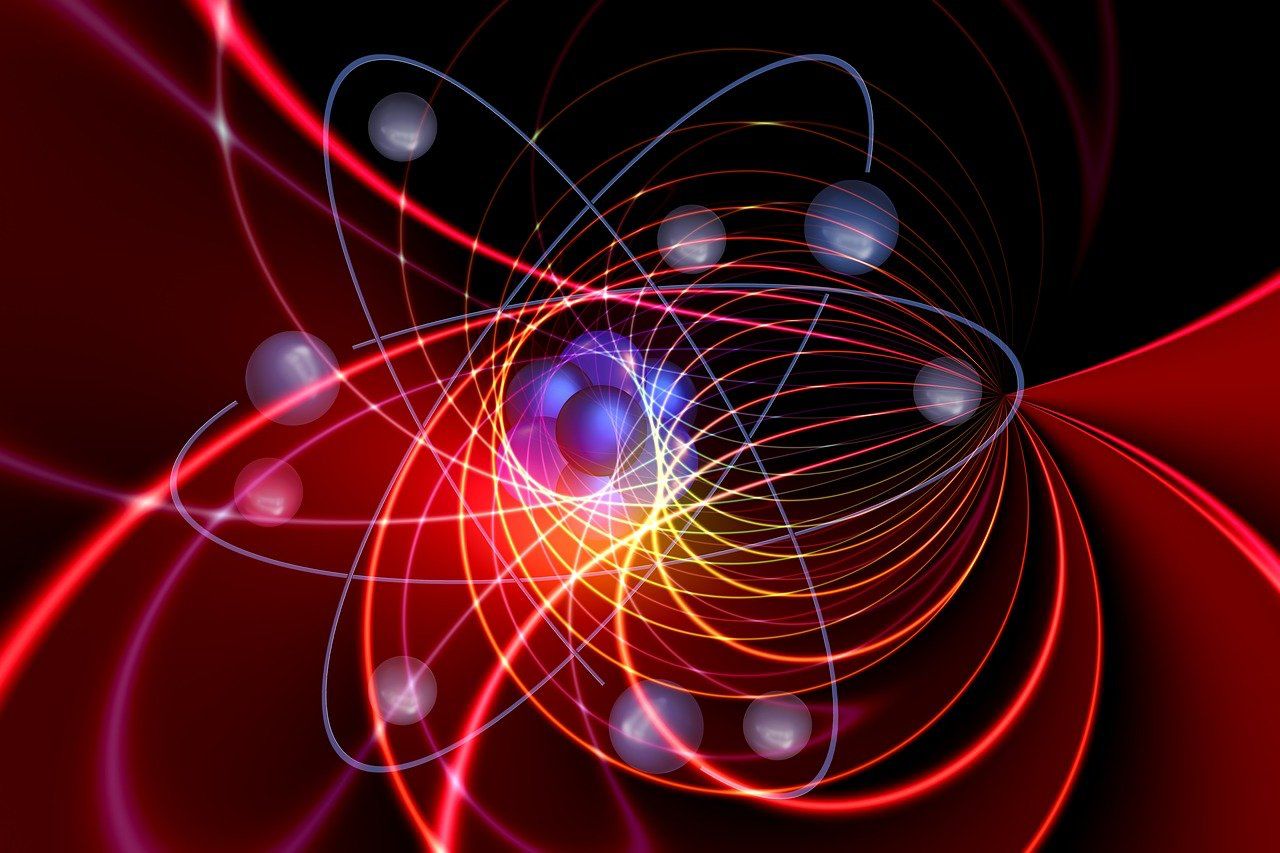Da quella sera piovosa del 13 marzo 2013, quando Jorge Maria Bergoglio, Papa Francesco, si affacciò per la prima volta dalla grande Loggia delle Benedizioni di San Pietro, la Chiesa ha vissuto 12 anni di pontificato per la prima volta di stampo gesuita. Il profilo di questo Pontefice argentino austero e dal carattere ruvido, in un primo momento, era stato interpretato dai porporati come il Pontefice che avrebbe “messo le cose in ordine“. In realtà, dall’opposizione assoluta all’aborto, cara ai tradizionalisti, Bergoglio mostrò l’altro suo lato quando tessé le lodi di Walter Kasper, teologo tedesco che avanzò ad esempio la proposta sinodale di riaccostare alla comunione chi si risposa civilmente.
Papa Francesco ha quindi ribaltato ogni cosa, destabilizzando la Chiesa, per qualcuno fortunatamente e per altri sciaguratamente. I primi in quanto convinti che solo così si sia potuta trarre in salvo la Chiesa da un destino stagnante e irrilevante. I secondi pensano invece che l’apertura e l’accoglienza al mondo abbia contribuito a determinarne l’irrilevanza. Risaputa la sua adesione alla Compagnia di Gesù dal 1958, Bergoglio è stato da molti interpretato come “Papa nero” a tutti gli effetti. Ma cosa significa?
Leggi Anche
Chi sono i gesuiti
L’ordine dei gesuiti venne fondato nel 1540 da Ignazio di Loyola, poi divenuto santo, negli stessi anni in cui avveniva lo scisma protestante che stava dividendo l’Europa. I Papi dell’epoca erano più che altro Principi rinascimentali impegnati nelle guerre e i gesuiti erano proprio uno dei gruppi creatosi per chiedere una riforma all’interno della Chiesa che potesse scindere il potere temporale da quello spirituale.
In pochi anni la Compagnia di Gesù divenne una delle fazioni più importanti della Chiesa cattolica, in grado di esercitare la sua influenza dall’Europa all’America e fino all’Estremo oriente. I gesuiti per questo motivo, sono spesso associati all’idea di essere assidui devoti al Papa e al loro Superiore Generale, ovvero il capo dell’ordine, nonché “consiglieri dei potenti“, con particolare attenzione a mantenere il contatto con qualsiasi potere. La loro fedeltà andava direttamente al Papa di Roma, spesso scavalcando anche i vescovi locali. Mentre, il Superiore Generale era ritenuto il “capo occulto” della Chiesa, che in un certo senso riusciva a “muovere” il Pontefice a suo piacimento e per questo chiamato il “Papa Nero”.
Nel ‘700, i gesuiti potevano esercitare un potere non indifferente tanto che i regni europei avevano deciso di espellere l’ordine dai loro territori, con l’accusa di voler sovvertire l’ordine sociale, di essere agenti del Papa e di corrompere la gioventù. Finché nel 1775, il Papa soppresse la Compagnia, diventando da quel momento un movimento clandestino.
L’ordine è stato poi rifondato nel 1814, quando Pio VII aveva fatto ritorno a Roma dopo aver trascorso anni prigioniero in Francia sotto Napoleone. In quegli anni i gesuiti si schierarono con la parte più intransigente della Chiesa che vedeva l’Illuminismo e la Rivoluzione francese un prodotto del demonio, quindi tra liberalismo, uguaglianza e secolarizzazione della società.
Dagli anni Cinquanta, però, la Compagnia di Gesù avvia una mutazione rendendosi quasi irriconoscibile rispetto alla Compagnia rifondata. Dalle posizioni intransigenti, infatti, i gesuiti passarono a posizioni molto più liberali. Tra le figure più riformiste appare l’americano John Courtney Murray, che in merito all’aborto aveva introdotto la distinzione tra l’immoralità del gesto e la possibilità o meno di trasformare il giudizio morale in una legge dello Stato.
Ma, chi apportò cambiamenti radicali fu Pedro Arrupe, Generale dell’ordine dal 1965 al 1983. Arrupe dettò la linea secondo cui occorreva realizzare la giustizia sociale e combattere la povertà. E proprio in quegli anni si andò sviluppando in America Latina una delle correnti che hanno maggiormente connotato la Compagnia di Gesù nel secondo dopoguerra, ovvero la Teologia della Liberazione. Movimento che in un certo senso influenzava Bergoglio con quella interpretazione degli insegnamenti cattolici in chiave dei più poveri, delle diseguaglianze sociali e dell’oppressione politica. Per i critici la Teologia non era altro che una versione cristiana del marxismo. Anche per questo motivo, la figura di Papa Francesco non aveva mai convinto dei tutto i tradizionalisti.
Papa Giovanni Paolo II ne fu un grande oppositore, accusando la Compagnia di essere vicina al socialismo e di rischiare di creare una frattura tra una Chiesa dei poveri e una Chiesa dei ricchi. Nel cercare di prendere la situazione in mano, Giovanni Paolo II arrivò a nominare personalmente e direttamente il successore di Arrupe nella Compagnia di Gesù, opponendosi al candidato più liberale che era stato scelto dalla Congregazione dell’Ordine.
In tutto questo però esisterebbe una sorta di legge non scritta secondo cui i gesuiti non dovrebbero e non potrebbero diventare pontefici, proprio perché il Capo dei Gesuiti ricopre quel titolo di Papa nero, che rappresenta anche un potere di contrappeso a quello di chi ha il comando sulla Sacra Romana Chiesa. Inoltre, Sant’Ignazio di Loyola aveva fondato l’ordine con lo scopo di raggiungere il popolo povero senza aspirare al raggiungimento di alcuna carica di rilevanza. Quindi, la contraddizione che permarrà con molta probabilità nella figura di Bergoglio è l’essere stato proprio un gesuita Papa.
© Riproduzione riservata